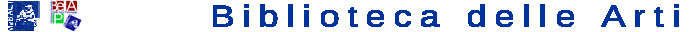Sei in: home page
> eventi > convegni
LA DEA DI SIBARI E IL SANTUARIO RITROVATO. Studi sui rinvenimenti dal Timpone Motta di Francavilla Marittima
Presentazione del Volume Speciale del Bollettino d'Arte
Roma, Istituto Svizzero di Roma, Via Ludovisi 48
07 aprile 2009
Il secondo tomo del Volume Speciale del Bollettino d’Arte relativo al materiale archeologico restituito all’Italia dai depositi dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Berna e dal Museo John Paul Getty di Malibu (oltre a quello tuttora conservato nella Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen) concerne i reperti (ancora essenzialmente ceramici, come nel precedente tomo I.1) provenienti dal santuario rinvenuto sull’acropoli del Timpone Motta di Francavilla Marittima nell’entroterra di Sibari, illegalmente scavati e trasferiti sul mercato antiquario d’oltralpe negli ultimi decenni del secolo scorso.
Si riferisce a frammenti importati di fabbriche greche, ad altri di produzione cd. coloniale (la maggior parte, in termini quantitativi), di produzione indigena, a terracotte architettoniche e ad oltre 50 manufatti in materiali diversi.
Le prime due sezioni del volume descrivono esemplari importati dalla Grecia orientale e dall’Acaia, oltre a quelli di tipo coloniale o locale da essi derivati (cd. East Greek-style e Achaian-style wares). La distinzione fra importazioni dalla Grecia orientale e le imitazioni locali non è sempre netta, e nell’ultima classe si possono trovare copie di vasi greci certamente influenzati dai centri greco-orientali o che, attraverso la combinazione di influssi da diversi centri di produzione, mostrano uno stile decisamente eclettico.
La terza parte del volume comprende i pezzi relativi alla ceramica designata come “coloniale dipinta”, più o meno influenzata dal vasellame importato dalla Grecia. Essa era realizzata nelle colonie greche o nelle regioni dell’Italia meridionale poste sotto l’influsso diretto delle stesse, secondo una linea di produzione indipendente che la rende molto varia dal punto di vista delle fabbriche, delle forme o della decorazione. Le analisi chimiche ancora da effettuare sull’argilla potranno definire meglio la questione dei centri di produzione, così come risultare senz’altro risolutive anche per attribuire una serie di pezzi, finora rimasti a margine della classificazione presentata in questo volume,
all’officina di un centro preciso.
Circa la questione della localizzazione delle officine ove questa ceramica “coloniale” trovata sul Timpone della Motta veniva prodotta, si è sempre ritenuto che essa fosse da riferire essenzialmente alla città di Sibari, o alla zona ad essa circostante. L’équipe del Groningen Institute of Archaeology (che effettua dagli anni Novanta del secolo scorso le ricerche nel sito) propone di distinguere fra una produzione ceramica “regionale” (intesa in senso geografico antico) estesa alla zona lucana e all’area del Metapontino in particolare, ed una “locale” propria della Sibaritide. Secondo tale ipotesi, confermata anche da rinvenimenti particolari, l’officina si trovava sulle pendici della collina ove sorgeva il santuario sulla Motta, e sarebbe stata attiva dall’inizio del VII sino alla metà del VI a.C.
Per concludere il sommario del Volume, nella sezione 4 si esamina la ceramica indigena, i Varia (ovvero diversi oggetti in faïence, in vetro, avorio ed osso, pietra e terracotta, spesso a carattere votivo) sono trattati nella 5, mentre una sesta sezione è relativa a poche terracotte architettoniche.
Nell’Introduzione Generale, infine, vengono fornite alcune anticipazioni sulla campagna di scavo condotta nel 2008 sull’acropoli del Timpone Motta dall’équipe olandese, poiché forniscono elementi utili per lo studio e la contestualizzazione dei materiali da Berna e Malibu sin qui pubblicati, pur nella consapevolezza che si trattava di un lotto “misto” proveniente dal mercato antiquario, come attestano alcuni esemplari estranei a quanto sinora rinvenuto nel sito di Francavilla.
Interverranno:
dr. arch. Roberto Cecchi, Direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, direttore responsabile del Bollettino d’Arte; dr. Stefano De Caro,
Direttore generale per i beni archeologici; Prof. Giovanni Pugliese Carratelli, Accademia
dei Lincei; prof. Dietrich Willers, Università di Berna; dr. Pietro Giovanni Guzzo,
Soprintendente archeologo di Napoli e Pompei, Presidente del gruppo di lavoro sul
Progetto Francavilla-Berna-Malibu; prof.ssa Marina Martelli, Università della Tuscia;
prof.ssa Frederike van der Wielen-van Ommeren, Università di Berna; dr.ssa Lucilla de
Lachenal, Redazione del Bollettino d’Arte.
E’ prevista la partecipazione, tra gli altri, di:
dr.ssa Caterina Greco, Soprintendente per i beni archeologici della Calabria; prof. Martin Guggisberg, Università di Basilea.
Si riferisce a frammenti importati di fabbriche greche, ad altri di produzione cd. coloniale (la maggior parte, in termini quantitativi), di produzione indigena, a terracotte architettoniche e ad oltre 50 manufatti in materiali diversi.
Le prime due sezioni del volume descrivono esemplari importati dalla Grecia orientale e dall’Acaia, oltre a quelli di tipo coloniale o locale da essi derivati (cd. East Greek-style e Achaian-style wares). La distinzione fra importazioni dalla Grecia orientale e le imitazioni locali non è sempre netta, e nell’ultima classe si possono trovare copie di vasi greci certamente influenzati dai centri greco-orientali o che, attraverso la combinazione di influssi da diversi centri di produzione, mostrano uno stile decisamente eclettico.
La terza parte del volume comprende i pezzi relativi alla ceramica designata come “coloniale dipinta”, più o meno influenzata dal vasellame importato dalla Grecia. Essa era realizzata nelle colonie greche o nelle regioni dell’Italia meridionale poste sotto l’influsso diretto delle stesse, secondo una linea di produzione indipendente che la rende molto varia dal punto di vista delle fabbriche, delle forme o della decorazione. Le analisi chimiche ancora da effettuare sull’argilla potranno definire meglio la questione dei centri di produzione, così come risultare senz’altro risolutive anche per attribuire una serie di pezzi, finora rimasti a margine della classificazione presentata in questo volume,
all’officina di un centro preciso.
Circa la questione della localizzazione delle officine ove questa ceramica “coloniale” trovata sul Timpone della Motta veniva prodotta, si è sempre ritenuto che essa fosse da riferire essenzialmente alla città di Sibari, o alla zona ad essa circostante. L’équipe del Groningen Institute of Archaeology (che effettua dagli anni Novanta del secolo scorso le ricerche nel sito) propone di distinguere fra una produzione ceramica “regionale” (intesa in senso geografico antico) estesa alla zona lucana e all’area del Metapontino in particolare, ed una “locale” propria della Sibaritide. Secondo tale ipotesi, confermata anche da rinvenimenti particolari, l’officina si trovava sulle pendici della collina ove sorgeva il santuario sulla Motta, e sarebbe stata attiva dall’inizio del VII sino alla metà del VI a.C.
Per concludere il sommario del Volume, nella sezione 4 si esamina la ceramica indigena, i Varia (ovvero diversi oggetti in faïence, in vetro, avorio ed osso, pietra e terracotta, spesso a carattere votivo) sono trattati nella 5, mentre una sesta sezione è relativa a poche terracotte architettoniche.
Nell’Introduzione Generale, infine, vengono fornite alcune anticipazioni sulla campagna di scavo condotta nel 2008 sull’acropoli del Timpone Motta dall’équipe olandese, poiché forniscono elementi utili per lo studio e la contestualizzazione dei materiali da Berna e Malibu sin qui pubblicati, pur nella consapevolezza che si trattava di un lotto “misto” proveniente dal mercato antiquario, come attestano alcuni esemplari estranei a quanto sinora rinvenuto nel sito di Francavilla.
Interverranno:
dr. arch. Roberto Cecchi, Direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, direttore responsabile del Bollettino d’Arte; dr. Stefano De Caro,
Direttore generale per i beni archeologici; Prof. Giovanni Pugliese Carratelli, Accademia
dei Lincei; prof. Dietrich Willers, Università di Berna; dr. Pietro Giovanni Guzzo,
Soprintendente archeologo di Napoli e Pompei, Presidente del gruppo di lavoro sul
Progetto Francavilla-Berna-Malibu; prof.ssa Marina Martelli, Università della Tuscia;
prof.ssa Frederike van der Wielen-van Ommeren, Università di Berna; dr.ssa Lucilla de
Lachenal, Redazione del Bollettino d’Arte.
E’ prevista la partecipazione, tra gli altri, di:
dr.ssa Caterina Greco, Soprintendente per i beni archeologici della Calabria; prof. Martin Guggisberg, Università di Basilea.

Bollettino d'Arte
Informazioni
Orari: ore 18