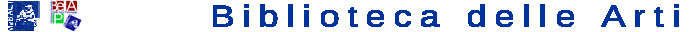Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d’interesse culturale
D. M. 28 marzo 2008
16 maggio 2008
La fruizione pubblica del patrimonio culturale italiano, ai sensi degli articoli 3 e 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42), è il fine istituzionale delle attività di tutela e valorizzazione che impegnano il Ministero per i beni e le attività culturali. Garantire l’accessibilità ai luoghi d’interesse culturale diventa quindi un compito prioritario da porre alla base di qualsiasi intervento di conservazione e valorizzazione. Sicuramente compito non facile, se si pensa, ad esempio, che l’inaccessibilità di gran parte del patrimonio architettonico è spesso legata alle caratteristiche fisico-costruttive delle fabbriche storiche, al punto da costituire in molti casi proprio quei valori che ci si prefigge di tutelare.
È evidente quindi l’importanza delle Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d’interesse culturale, proposte dalla “Commissione per l’analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali”, formalmente adottate con D. M. 28 marzo 2008, pubblicato sul supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta ufficiale n. 114 del 16 maggio scorso.
Il documento è rivolto a tutti coloro, architetti e ingegneri in primo luogo, funzionari di amministrazioni pubbliche o liberi professionisti, chiamati ad affrontare, seppur con ruoli diversi, il tema dell’accessibilità nell’ambito dei luoghi di interesse culturale. Nel predisporre le Linee Guida si è cercato di superare la logica da manuale di progettazione, evitando di suggerire soluzioni preconfezionate. Il testo si propone come strumento per stimolare la riflessione su un tema la cui complessità viene spesso sottovalutata, al fine di superare la prassi corrente della semplice ottemperanza normativa, per far rientrare l’istanza dell’accessibilità, fin dalla genesi del processo progettuale, nell’ambito del più ampio problema della fruibilità di un bene culturale nei confronti della collettività, ossia la base stessa della disciplina del restauro.
Le varie tematiche sono state analizzate nella complessità di tutte le forme di disabilità, ponendo particolare attenzione ad aspetti talvolta ignorati (si pensi ad esempio alle cosiddette barriere percettive), fornendo anche suggerimenti di tipo progettuale laddove non sono stati riscontrati specifici riferimenti di legge. Si tratta di un documento sinergico – alla cui definizione hanno collaborato rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, docenti universitari, esperti della materia, componenti delle principali associazioni del settore – che si presta a conservare la caratteristica di documento aperto, sempre rivedibile e aggiornabile in quanto, avanzando le conoscenze e gli studi, esso dovrà necessariamente adeguarsi ai futuri sviluppi e alle esperienze elaborate.
Informazioni