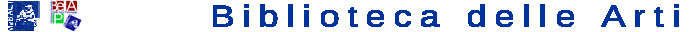All’alba della realizzazione di uno dei film più celebrati e ferocemente discussi sulla vita di Cristo, Pier Paolo Pasolini scriveva una lettera ad Alfredo Bini, in cui egli stesso intendeva far comprendere quali forze interiori lo avessero spinto al concepimento di un tale esperimento cinematografico:
“[…] . Dal punto di vista religioso, per me, che ho sempre tentato di recuperare al mio laicismo i caratteri della religiosità, valgono due dati ingenuamente ontologici: l’umanità di Cristo è spinta da una tale forza interiore, da una tale irriducibile sete di sapere e di verificare il sapere, senza timore per nessuno scandalo e nessuna contraddizione, che per essa la metafora “divina” è ai limiti della metaforicità, fino a essere idealmente una realtà. Inoltre: per me la bellezza è sempre una “bellezza morale”: ma questa bellezza giunge sempre a noi mediata: attraverso la poesia, o la filosofia, o la pratica: il solo caso di bellezza morale non mediata, ma immediata, allo stato puro, io l’ho sperimentata nel Vangelo. […]”.
Ne deriva un rapporto, da parte di Pasolini, puramente “artistico” con il Vangelo: che intenda trascendere i limiti logicamente imposti da qualsiasi analisi e proposito ottusamente laici o religiosi. Risulta evidente quanto la scelta di un tale argomento fosse destinata a riversarsi all’interno della società del tempo in una feroce (e infinita, e insensata) contesa fra questi due poli. Ciò che invece, in quel viscerale amore per il "Vangelo secondo Matteo", stringe la coscienza di Pasolini è, al di là dei prevedibili preconcetti, il desiderio di raccontare Cristo nella sua più rivoluzionaria e straordinaria umanità. E nel fare ciò Pasolini abbandona coraggiosamente gli intenti razionalistici tipici di Accattone per abbandonarsi, al contrario, a una furiosa ondata irrazionalistica, sospinta da matrici intellettualmente oneste, quali sempre furono le sue, e da una ricerca fortemente antropologica.
A cinquant’anni dalla realizzazione del capolavoro pasoliniano abbiamo l’occasione di rivivere "Il Vangelo secondo Matteo" nella sua dimensione più poetica, e di mettere a fuoco il rapporto del regista con la città di Matera, che, nell’estate del 1964, divenne Gerusalemme. La mostra, intitolata "Pasolini a Matera. Il Vangelo secondo Matteo cinquant’anni dopo. Nuove tecniche d’immagine: arte, cinema, fotografia", ci permette, oltre che di ricordare e riflettere sull’opera pasoliniana, di ripercorrere un momento importante della storia di Matera, che, in quegli anni di profonde contraddizioni, divenne meta di artisti, fotografi, registi, documentaristi, architetti, sociologi e intellettuali, che diedero un grande contributo alla ricostruzione di quel quadro così movimentato e incerto che fu il Mezzogiorno degli anni Sessanta.